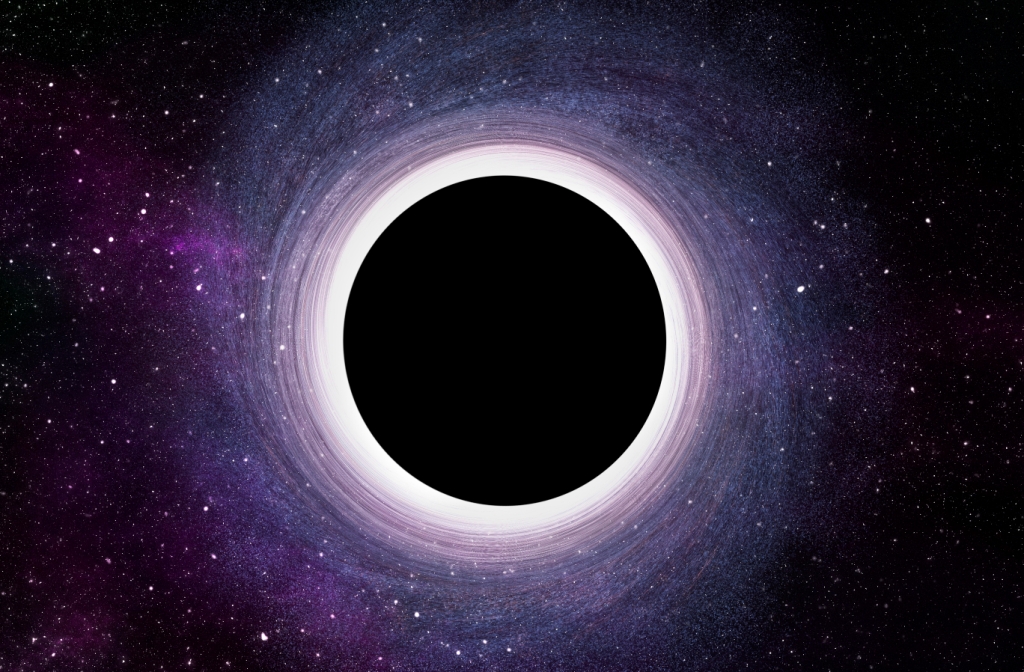Il treno di ritorno da Milano era in ritardo di pochi minuti, ma importava poco. Ci aspettavano a cena i miei genitori, perciò non c’era bisogno di preparare nulla da mangiare. Né, quindi, dovevo fare la spesa, né Maurizio doveva improvvisarsi chef all’ultimo momento sfoggiando la sua solita cucina grassa che, tra l’altro, d’estate non è che sia poi così indicata.
La riunione era andata bene: avevamo visto i nuovi applicativi per la gestione delle fatture: un software efficacissimo, che avrebbe aiutato a monitorare, all’istante, i budget dei vari uffici, se questi sforavano o avevano un accantonamento che potevano ancora utilizzare.
Ma soprattutto, questo benedetto software ci avrebbe permesso di essere più puntuali con i pagamenti. Più che altro per evitare lo stillicidio di telefonate che, di mese in mese, ci vedeva coinvolti – me come responsabile dell’ufficio amministrativo, ma anche i miei due collaboratori – nell’inventare le peggio scuse per tenere buoni i fornitori che aspettavano i pagamenti da più di 30, 45 giorni. Manco fossimo un ministero. Ci occupiamo di sistemi di allarmi e antifurti ed è vero, siamo una multinazionale, eppure… eppure ormai avevamo finito le scuse, anche coi fornitori con cui lavoravamo da pochi mesi.
Semplicemente avevamo imparato a ripetere che «a breve avremmo provveduto al pagamento», e che «intanto avremmo sollecitato la direzione generale per l’autorizzazione».
Un fantastico meccanismo di scaricabarile che nel breve periodo continuava a salvarci.
Nel frattempo, eravamo arrivati a più di metà del nostro viaggio in treno. Il paesaggio era quello della Toscana, dove il telefono a volte aveva zero tacche. Meglio così. Il collega accanto a me (l’altro era rimasto in ufficio a presidiare) si era addormentato. Io mi infilai le cuffie e aprii il canale Youtube di Ligabue sull’Ipad. Lanciai un video, uno qualsiasi, a me le canzoni di Liga piacciono tutte.
Provai poi a chiudere gli occhi, ma non avevo il minimo sonno nonostante (come avete visto) la mia difficoltà di passare notti serene. Preferii comunque serrare le palpebre, più che altro per estraniarmi e chiudermi dentro una campana di vetro virtuale. Il fruscio della velocità del treno non mi disturbava, quasi non riuscivo a sentirlo. In cuffia c’era Cosa vuoi che sia, la canzone è quasi una ballata. Mi feci indietro con il capo, strusciandolo sul poggiatesta del sedile. La cervicale di colpo si riattivò, i muscoli mi davano un leggero fastidio. Poi riaprii gli occhi. Davanti a me, in fondo alla carrozza, nel passaggio che porta a quella successiva, c’era un signore che fumava una sigaretta elettronica mentre leggeva un documento. A un tratto, alzò lo sguardo e incrociò il mio.
Mi sentii per un momento in difficoltà, eppure… ma sì, certo, io quel signore lo conoscevo!
Avrà avuto una cinquantina d’anni, forse qualcosa in meno. Capelli neri, probabilmente tinti, leggermente lunghi. Una specie di Andy Garcia di provincia, ma indubbiamente affascinante.
L’uomo continuò a guardarmi, a me veniva da sorridere. Forse arrossii, di solito appena avverto uno strano calore in viso abbasso lo sguardo. Mi sentii allora un po’ scema e chiusi di nuovo gli occhi.
Ma non potei smettere di pensare: dove cavolo l’avevo già visto?
Al momento di riaprire gli occhi, nel sedile di rimpetto c’era un signore incravattato che lavorava al computer. Accanto a lui una tizia che non aveva mai smesso di parlare al cellulare (per fortuna a bassa voce) da quando eravamo partiti. Nell’altra fila… Ecco! Nell’altra fila c’era un posto vuoto.
Ecco dove avevo visto l’Andy Garcia dei poveri!
Mi venne allora da cercarlo di nuovo. Spostai le iridi a destra, per scoprire se lui era ancora lì.
Ma certo che era ancora lì, e mi stava continuando a fissare!
Stavolta, però, con uno strano sorriso subdolo.
Strinsi le mascelle. Probabilmente feci un’espressione strana, come per dire «Hai visto? Ci siamo beccati un’altra volta!».
Il fatto però è un altro. Il fatto è che non ci sono più abituata, a questi scambi di occhiate, di attese, di inseguimenti e di controlli a distanza, per vedere se sono reciproci. E soprattutto simultanei.
Presi anch’io il cellulare e mi alzai, dirigendomi però dall’altra parte del convoglio. Magari in bagno. Sì, in bagno era meglio, così Andy Garcia non mi avrebbe seguito con la scusa di invitarmi a prendere un caffè. Pochi passi ed entrai nella toilette. Mi guardai allo specchio, mi diedi una pettinata con le mani. Sembravo essere in ordine.
Pensai allora che ci sono. Che ancora, ci sono. Che con il mio tailleur color pesco ero bella. Che ero forte, quasi invincibile. Sentii poi che avevo voglia di tornare a fumare, come quando avevo 23 anni ed ero alla facoltà di economia.
E magari sì, anche di farmi una canna.
Di essere insomma libera.
Trasgressiva.